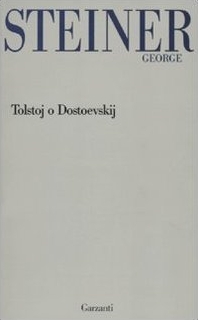Antonio Verri
Antonio Verri
La cultura dei tao
a Damiano Stefano
<<Era ancora luna chiara di gennaio, giovane luna. Il freddo di quell’inverno tagliava le gambe. A casa c’era poco. Voi figli uscivate coi pantaloni gonfi di fichi secchi, le domeniche le passavamo con della pasta d’orzo, con bocconi che m’ingegnavo d’insaporire per voi signorini seduti su sedie altissime. Qualche volta cuocevo sciscèri di pollo, qualche altra volta si ammazzava una pecora che stava male, poi c’era il pane cotto e il lardo che tutto condiva…
Era questa la vita e voi avevate grandi occhi da birbanti…solo tu, ecco, imbronciavi un po’ più spesso sui carrettini che da me ti costruivo…
L’inverno fu tristissimo quell’anno. Non era ancora febbraio ed era già bella e finita la scorta della monda.>>
La madre. La mar. La scorta della monda. Cioè, grossi rami inutili ma soprattutto le giovani cime, a colpi di forbice e serracchio, per impedire la crescita, per impedire quell’avanzo in armonia di un albero bello sì, temerario sì, ma senza frutto.
<<Se no dà in furia>>, dice la mar. Col tremore di chi di quella furia è madre.
Caprarica di Lecce, 30 Aprile 1986
* * *
Tanto ho appreso, altrettanto mi è stato insegnato. Mi è stato insegnato, per esempio, che per molti fiori di giardino esiste un corrispondente selvatico: e allora ho scoperto che mi era caro il profumo del secondo dei due tipi di ciclamino, rose, mimose, margherite…
Mi è stato insegnato – ma poi l’ho sperimentato da me – che vivendo, stando quanto più possibile lontano dal nulla, non si può fare a meno della saggezza e del piacere curioso dei proverbi, dei mille proverbi che dalla terra nascono; che i proverbi aprono al mondo, a variegate realtà, che niente c’è di tanto misterioso, di tanto affascinante, di tanto poetico, quanto un proverbio che si dipana al punto giusto, al posto giusto; che attraverso i proverbi è tanto magica, tanto plastica l’interpretazione del mondo che niente, nessuna cosa sulla terra, mi è parsa, mi pare così naturale, così saggia, così strapiena di candore…
Mi è stato anche insegnato, con ardore, ad apprezzare – ed io continuo a guardare e amare con tale ardore… – poveri oggetti (stilizzati, essenziali, ma solidi), situazioni le più umili, ma portate con tale dignità, che serenità, buon senso, innamoramenti al limite del pianto, sono cose che oggi io, figlio di questa cultura, posso opporre a volte con tale incauta destrezza da rischiare di bruciare, con legna d’ulivo, il sibilo lungo di una cultura millenaria…
Cambia, cambierà, di molto il volto della campagna, degli aggregati umani, di interi paesi: è cambiato dal dopoguerra ad oggi, cambierà ancora tra due, tre generazioni. E cambieranno naturalmente anche abitudini, modi di lavoro, rapporti…, ecco, quello che non cambierà mai sarà l’idea del dialogo con la terra che l’uomo ha stabilito dal tempo dei tempi, il grosso respiro, il sibilo lungo che si può udire solo di mattina, mirando nella vastità dei campi, con accanto sentinelle silenziose gli alberi d’argento…
Ma torniamo al racconto, nostra sede, ad uno dei mille rivoli del racconto…al padre che nella canna ricurva della pipa di pietra infila una di quelle chiavi di cinquant’anni fa, la fa partire, ecco, adesso gira nell’aria, la canna percorre il tondo della chiave, adesso basta un impercettibile armonioso movimento della mano per far andare il tutto. Il padre, nell’eterna sua magrezza, a capo chino, severo, somiglia un pìstico sognatore di lucchi, un tenero rabdomante di chissà quali sotterranei giacimenti, di chissà quali gore di distanza. Di rado bofonchia, è come assorto nel suo gioco, con la nequizia, la permalosità di sempre. Dal giro della chiave nasce un suono, un leggero crepitìo…
Le figlie sposate in altri paesi (quanto sono cambiate!) rientrano, fuori è il venticinque aprile, San Marco, giorno della fiera, con i venditori “napoletani” di Martina, di Ceglie, di Corato, che dal barese, dal foggiano si riversano in questa come nelle altre fiere che in tutto il meridione hanno scadenze regolate da cicli agricoli, attese con genuina allegria, infinita baldanza, con intensità pari solo alle “straordinarie” mercatanzie che verranno acquistate: lunghe teorie di attrezzi da lavoro, finimenti, “quernamenti”, solidi utensili modellati sul vecchio tipo, piatti per l’occasione vengono dichiarati “infrangibili”, rosette per uno spruzzo a largo raggio, lo spargisale da campagna ultima novità, e poi creta rozza, creta smaltata, cippi, vasi, campanelli, chicche sonore dei buoni tempi andati, la dignità solita di una baracca di cappelli, ogni anno al solito posto, sotto il castello (anche i cappelli hanno un loro posto importante nella vita di un paese… a cominciare da uno sfanciato, di piché, per finire a quello che mettono nella cassa da morto: serve al congiunto per presentarsi a Dio!), e ancora, cupeta e mostaccioli, tovaglie, corredo, polveri e sementi per la campagna, Lattuga gigante, Spronelle di Corigliano, Cicorie rizze; e poi, è un affarone il nuovissimo pupazzo gigante per far bolle di sapone?
Bisogni, necessità per tutto l’anno, futilità le più ingenue, cose da conservare sul comò, la scapece da consumare a mezzogiorno, la faenza (bicchieri, tazze, chincaglierie) da mettere in mostra nell’elegante credenza, grida, fatti, parole che dei fatti trasmettono il suono… è questo il paese, è questa la cultura del sibilo lungo!
Sta per arrivare la banda… C’è armonia, c’è avventura, c’è completezza in tutto in quei posti. E quando anche quest’armonia dovesse esse rosa in qualche punto, ecco, c’è la madre riparatrice, ispiratrice, che aizza all’ardore, al furore di parole… è lei la depositaria, è lei rappresentante di questo mondo. E la stagione è l’inverno !
L’inverno era di quelli allegri, mai mesti, del pirichilli. Di quelli che poi se vengono qualcosa dovrà succedere, qualche nato importante, ribeglione, o qualche grande morto che tiene fino al freddo. L’inverno del pirichilli. Freddo cioè, dal mangiarsi sul serio anche cardilli. Stranamente freddo però, ecco, tanto da panegorisare contrade, crocicchi, pianori, interi paesi che solo per l’occasione bruciano bitume, resti di olive, trucioli, lievi napte di legno trinciato. Tutto. Tutto.
Inverni del genere arrivano ogni due, tre generazioni, quando ormai i ragazzi natanei non servono che loro stessi, esplodono di solito con l’accensione dei fuochi di metà gennaio ma sono nell’aria fin dall’ultima fiera di dicembre: li annuncia con testardo, sonante furore di parole, l’òrico venditore dal pelo rosso, l’incomparabile mestatore, molitore di segni e di linguaggi.
Arrivano così in questi strani posti questi strani inverni, come falsi castighi, come cose nibate, indicibili, con lo stupore gelato che sosta su case basse, che dà vita rotante ai vicoli, che cala nel fondo dei frantoi, risale, mulinella nei secchi del pozzo, agli usci delle porte; si perde poi sui terrazzi, su schegge di pietra che tengono, uno sull’altro, solidi massi fuori squadro. Uno sull’altro. Più su, più su…
-‘Na lusione, ‘na lusione, dice la mar che, con sciroppo di lauro e di mortella, in inverni come questo, separava, puliva e preservava i sonni, le parole, le iose di un figlio che segue l’abuso, che vive per l’eccesso… La mar, la mar, che vede del figlio quel che con lei è nato, che non sa di quell’altro che brucia sperso negli inverni, di quell’altro dagli occhi spalancati dal sogno, dalla voglia di farcela, per il padre, per lei…
Ecco, la mar dice del tempo cambiato, di quando la navetta correva legata a bande di colore, ci ripete che vededi noi pilladori quel che con lei è nato. Durano conti… Durerà quel nitore di carta, o mammaniva, quel narrare brandea di teneri suasori?
Ecco, la mar m’abboffa come se dovesse nicare. Ma nicare non nicherà, passerà come lento fiume il tempo – l’idea del tempo che passa, del tempo cambiato, della navetta che corre a bande bianche a bande di colore, la dette lei, lei l’ideò quando, intristita dall’umido del cucinino, disse: “ Un tempo mettevano zorfo in questi uncini! ”.
Ecco, la mar m’abboffa come se dovesse nicare…parole e suoni avviticchiati alle cose che mi racconta, alle cose che mi avvicina col solito decoro, parole che copre nei canestri – le parole del figlio a zacchinetta – per farle maturare, per far colar quel croco che al figlio assicuri la narrazione del santo pancro, l’oromìa, l’olòfora, l’incanto; xhe questo che cuce sia palisma, òrico, sonoro, dolce impanto.
Mar, o mar, nicare non nicherà, nicare proprio non nicherà!
Oh nive, oh nive bianca, oh tantanton de barba bianca!
– Figlio, sempre qualcosa mette ciglio. La mar. Mi dice ancora del tempo cambiato – passano quadri piscatori – del tempo che oggi corre dietro al fiscolo del niente… Lei, intanto, quando non balla tabacco secca palate, ha mani sapienti, bianche cedono coperchi pressati nove volte… e invece di boccoli di pane, frigge piccoli tesori del tempo dei suoi tramonti rossi!
– La prima volta che vidi un treno gridai “ passa la tuzzuìa, passa la tuzzuìa ”, e la campagna bianca rispose “ passa la tuzzuìa, passa la tuzzuìa ”, e la contrada col nero dei camini “ passa la tuzzuìa, passa la tuzzuìa ”,e i miei morti e la mia casa, i miei viaggi e il mio biroccio, e il mio vestito e il mio terrazzo, tutti insieme gridarono “ passa la tuzzuìa, passa la tuzzuìa ”, e ancora “ passa la tuzzuìa, passa la tuzzuìa…! ”.
Ecco, dissi, ancora una volta prima di spegnere, con un suono grave che ancora ho nelle orecchie: “ Sarà quel che sarà, ma tu cerca… al mondo stiamo per cercare!”.
È vero, o mar, non sono ancora passato al libro vecchio, non riesco a seguire il tuo “ quanto conta il saper fare ”, le parole, soprattutto per me, sono un po’ come cirase (una tira l’altra), febbraio è sempre un mese corto e amaro, le serpi sono ancora nascoste e le rane non “cantano” ancora… ma sono il figlio della storia del miglio e del mortaio, della camomilla dorata della sera, quello che perdeva gli occhi su quel vecchio comò a casa della nonna, con la campana del santo, due candelieri argentati (quelle cose che in una casa arrivano non si sa come, da tutti considerate pregiate, si conservano con orgoglio smisurato, diventano simbolo della famiglia, a volte; quelle cose che restano negli occhi dei piccoli di casa anche quando la casa non c’è più…), un centrino sul marmo, qualche fiore la cui continua freschezza è l’effetto di un incanto… Tutto fermo là, pissocerato, quasi un altare al dio del buon consiglio che vive, con altri folletti, nel rosso fumante della terra appena “scapolata”… Ma cercate dovunque, nelle foto qui dietro, altrove, ci deve essere quel vecchio comò, ci deve essere quella vecchia credenza (il figlio, nella nicchia accanto, rubava liquore giallo), una cassapanca essenziale e capiente, il cassone dei fichi secchi, il saccone di fronze, la monaca scaldaletto, la cucina sempre bianca, lo stipo di legno che conservava ruote di creta che chiamavano piatti, la paglia nella pagliera, l’“acchiattura” nella stanza accanto…
Ma è ancora inverno. Non è cambiato molto, o mar. Oggi girano squadre per la monda come allora. Il paese intero è diviso in squadre, come allora. Mi dicono che hanno le loro leggi, regole loro, ogni squadra ha una sua carta di comportamento, di tenuta. A volte, o mar, sono così necessarie alla vita del paese che mondare mondano un po’ tutto (ogni squadra ha un suo declaro, ecco, e sfronzare gli eccessi… non è soltanto un vezzo!). Comune a tutte, però, è la proibizione del vino, del vino prima di salire: svettare l’olivo, far sì che cresca in chioppa, non è cosa da niente!.
Solo qualche capomonda permissivo, distratto, nembrotico, istigatore, a volte permette il vino, permette di danzare, il tsiritirò… e allora l’albero è libertà, piacere e tentazione, riso, sghignazzo, intolleranza… ecco, riprende con foga la navetta, torna a rotar la tuzzuìa, ricresce, bòffolo, il sogno…
– Un tempo avevo occhi che tutto miravano. Tuo padre giovane…
Ma è sempre inverno: si attenua il dolore al ginocchio, tutte le storie sono cariche di lusione che in altri posti un nonno favolista vendeva a costo di decoro, storie intorno al tavolo, col fuoco, col padre appeso al miracolo della radio, con la foto del figlio lontano bene in vista, gli scampoli di una figlia sarta, uno specchio senza cornice, ad angolo, interrogato chissà quante volte, chissà quante volte odiato…
Durano conti…! Parole nugose, cantilenanti, sogni, costruzioni le più audaci (da far impallidire scrittori di professione), artifici, fisime di smalto, possibili solo a terreno cherso, nella stagione morta, o di sera quando il ragazzo figlio ascolta, risponde, sorride, anche se il suo pensiero, lui stesso, è sulla ciminiera accanto, dove un galletto, nella sua muta nettezza a mezz’aria, compie giri quasi completi…
La letteratura di questa gente magra, dalle mani callose, è fatta di fole e di angiolesse, di orchi benevoli, di tao che girano a mezz’aria, di spiritelli biricchini, di donne di pasta cresciuta, di fibule, glimpe, pènule, di purissimi cavalieri che di notte riposano sui tetti bassi delle case bianche, o nelle corti, sotto la prèula, accanto al gelsomino, o in stàbule di campagna sopra lettiere di sarmenti, nella paglia (sono loro, i cavalieri, che di mattina prestissimo, innaffiano d’argento gli olivi, intonano il colore delle margherite, spargono a caso fiori di lampone…), succhiando liquirizia a pesciolini, sciogliendo in bocca un tripizzo dolcissimo, facendo capriole inaudite, lasciando biglietti a ragazze dai lunghi capelli, sacchetti di talleri d’oro, colore per le guance, crinoline e merletti per gli anni a venire…
La letteratura della mar era il narrare dei sogni il mattino dopo, degli idoli suoi, i morti , che venivano a trovarla – fresca, mai turbata, come fosse un altro sorriso, un altro abbraccio alla sua gente…
Ecco, durano i conti… e ci sarà sempre un povero favolista a narrarvi di un cuecolo di neve che molto tempo fa dei ragazzi festosi, goliardi, furenti, cominciarono ad appallottolare nella piazza bianca per farlo poi rotolare, alimentandolo, per una discesa in paese: tre mesi restò giù senza squagliarsi… Tutti tornarono. Tutti. Meno Stefan. Stefan, cominciò a dire la mar, fu rapito dai tao!
– Credeva fosse uno dei soliti pupazzi di neve, uno dei soliti pupi bianchi che da ragazzi si fanno, e uscì di casa col passello per fornarne gli occhi… Non l’ho più visto. Chissà… Il portamento, l’allegria, tutto in lui poteva far innamorare un tao, un lieve tao, un tao del freddo, uno di quei tao insolenti che saltellano a mezz’aria mangiando girandole di neve, col corpo in piena luce…
– Tuo padre fece poi una guarnice ai suoi grossi occhi chiari, e da allora aspetto…Oh, aspetto la tornata dei tao, il mio ribaldo!
La mar. La solita storia. La sentivo cento volte al giorno, ne sapevo pieghe e accenti, ogni particolare, tutto quello che accadde, tutto quello che un tempo rese possibile. Era ormai diventato tutto così assurdo, così strano, così ingannevole, che sia io che lei, all’improvviso, eravamo entrati come in un vortice nugoso, in una grande ruota bianca, avvolti, per nostra stessa volontà, per tacito patto, nel manto perlaceo di parole sonanti, favolose, antiche, cantilenanti…
– Come! Lasciarsi prendere dai tao!?!
La mar.
Parlava di un figlio che a vent’anni s’era allontanato da casa gridando come un matto, correndo festoso verso il cueculo di neve che stava per nascere, che già cominciava a rotolare… Molte madri non videro i figli per tre giorni, quanto durò l’inusuale appallottolamento. Poi tutti tornarono, meno lui. Meno Stefan. Stefan non tornò.
– Il mio magnuccio! La mar.
I tao. Da quel momento la mar cominciò a parlare dei tao, s’inventò i tao, questa specie di folletti predoni, di elfi colorati, che vivono a mezz’aria, che così maleficamente sono entrati nella sua vita… Poi s’inventò dell’altro. Del figlio in stàbula, un casolare lontanissimo – ne vedeva il lumicino -, perso a giocare a zacchinetta. Perso perdente.
Altro, tanto altro. Tante sorti del figlio s’inventò, tante vite, tante possibili buone soluzioni, pensate per piacere di spasimo, per quel follicolo di voluttà che ricopre – li argenta – i percorsi di vane illusioni. La mar.
Era stato proprio un inverno tristissimo quello. L’inverno della calata dei tao. Un inverno come pochi altri inverni. Così amaro!!!
Ecco. La cultura dei tao. La mar. La sua costante autorizzazione al furore, il suo costante invito a fabulare, ad abusare della lingua… E tutto ciò che entra tra le nostre righe è quel croco che non ha vissuto, che ha sempre inseguito, di cui ci ha sempre parlato, e che ora per noi è suono, armonia nascosta, nive, nive farinosa…
I tao ci sono sempre in un paese. I nostri paesi ne sono strapieni. Esistono anche per questo i campanili nei paesi.
L’idea del campanile arriva quando la gente è esasperata, quando non ce la fa più a sopportare i tao. Formelle su formelle, cotto su cotto – in un silenzio operoso – la gente alza il campanile per sorprendere i tao, per piombare di sorpresa sui tao come sempre intenti a biffarsi dall’alto le zone in cui predare.
Bisogna dire, però, che i tao sono dei predoni fascinosi, a volte quasi necessari… guardate la mar, per esempio, lei è ormai al punto che coi tao ci gioca, azzarda, retrocede, favoleggia, lei ormai è di quel mondo a mezz’aria, non esiste altro mondo per la mar – dapprima, un po’ come tutti qua in paese, covò il campanile, con furia, con disperazione, poi tutto cambiò, cominciò ad usare, a viverci nel campanile, ad un certo punto cominciò, con gessi neri, a scrivere sui muri del campanile, dapprima strofette al figlio, poi le canzoni della giovinezza, le contra che lei cantava così bene, i cori d’inverno tra gli ulivi, ma anche scioglilingua sui tao, descrizione dei loro giochi, bagatelle…
Andavano in aria i tao, alle angiolesse obìte, ai transiti dei loro padri elfi, in oblivione completa, con lo stupore dell’ebbro, galoppando ossessi sul vapore, sui tetti color pigna, sulle madri di Robinia, sulle madri dell’oro di coppella…
– Un tempo avevo occhi che tutto miravano. Tuo padre giovane… La mar. Quelle che lei mirava sono poi cose che hanno fatto la mia vita.
Quando stavo con lei, figlio com’ero di una dea dell’aria, quando camminavo con lei, non c’era necessità di sprecar parole, erano gli occhi a raccontare, era negli occhi che riuscivamo a fermare, in un attimo di mille parole, gli eccessi, gli scoppi, lo smorire, la meraviglia… Non esisteva niente allora, niente dei travagli di tanti giorni neri: lei era all’improvviso una lieve festuca dorata, era in quella fibula d’oro giallo al petto, nel regno sempre bianco della tuzzuìa, nel lumicino lontano delle fortune che ogni sera tremolavano in una stàbula d’uomini persi a zacchinetta, nel tripizzo che in bocca squagliava, nelle margheritine di camomilla, nelle fresie in alto sul portone…
Chissà se poi la mar avrebbe, in realtà, voluto una vita diversa!
– ‘Na lusione, ‘na lusione, mi pare di sentirla ancora adesso.
– Sotto la neve il pane, mi ripeteva. A me piaceva sentire quelle cinque parole una dietro l’altra, e domandavo, domandavo continuamente. Come?, il pane sotto la neve? Certo, diceva lei, con voce di velluto, il pane sotto la neve, proprio così, il pane sotto la neve: quando c’è neve – tanto meglio se è farinosa – che copre un campo seminato, il seme è costretto a lavorare sotto, il raccolto è rassicurato.
Il ragazzo continuava a chiedere con avidità, la mar cominciava con le sue storie, i suoi “segreti”. Per niente altro c’era posto. Tutto intorno la vita lievitava.
La sera prima di Sant’Antonio andavo dal fornaio – la mar -, ordinavo un canestro di buon pane, poi la mattina di buon’ora lo portavo in chiesa, lo distribuivo… Non mettere mai il pane sottosopra, porta lutti, porta disgrazie… Potevi vincere, con una cotta di pane fresco, persino la Madonna all’asta… Prima di un matrimonio si faceva doppia cotta di pane, allora i matrimoni avevano il pranzo in casa…
Anche i tao erano come storditi quando in paese si faceva il pane. Sostavano a gruppi sul tetto del forno, volavano così in basso che a volte urtavano i galletti sui camini; qualcuno con improvvisa spavalderia, approfittando della rapida apertura del forno, vi si infilava dentro, nelle fiamme, attirato dal pane che cuoceva: se ne usciva u po’ frastornato, stravolto, rosso, ma…quattro passi ed era in volo!
Parlava, la mar, di freddo, di neve, mi raccontava la storia dei tre giorni della merla… io ci legavo il pane (non sapevo pensare ad altro, ormai), il panetto di lievito acido che il fornaio conservava per la famiglia del giorno dopo, la màttira di legno chiaro, le tàule con costati, senza costati, il miracolo, la meraviglia della pasta che cresceva…
I racconti continuavano. Una grande fame ma una grandissima dignità. Le generazioni di gatti tutti somiglianti. Il teatro che cinquant’anni fa approdò in paese, la fabbrica di tabacchi ne fu il palco, con le attrici piene di trini e pizzi, colli lunghi… “e noi non riuscivamo a tenere in casa i nostri ragazzi”! Le storie di gelosia, la gente magra, le case basse, la vita essenziale; anche le morti erano importanti, se il morto era un ragazzo o una ragazza, era preso dai tao, diventava un tao perfetto, uno di quei tao di meraviglia… Era questa la vita di un paese!
Ma il favolista, di casa in casa, comincia a narrare di un essere legendario, selvaggio, uno spirito silvano dei campi, dei paesi, che è un tutt’uno con alberi, foglie, boschi, un orco benevolo, uno spiritello biricchino, bizzarro, lieto e allegro anche quando dovrebbe essere triste; mangiaparole, mangiasuoni, un po’ buffone, mai sazio, mai saggio. Questo essere è il Bel Tempo. Arriva allora la Primavera. Le rane cantano la fine dell’inverno; son fuori, inoffensive, le natrici d’acqua; le mulacchione, le ragazze inesplose, rosse, continuando raffinate e lievi trame di ricamo, aspettano il loro ambasciatore (“arriva l’ambasciatore, oilì oilà, a cercare la più bella”), il loro principe azzurro. Se lo immaginano in divisa… Ed eccolo che arriva, per le più fortunate: è un musicante del Gran Concerto di Gioia, è un postino aitante che lavora al nord, è un carabiniere che tornando a casa lucida scarpe e divisa…
È in arrivo anche la banda, i tao saltellano come impazziti sulle berrette dei musicanti che continuano a sbandare, il cielo è più basso, le stelle lucenti (tendono ad offuscarsi solo quando in paese arriva la cassarmonica e gli occhi brillano e si corre verso il centro illuminato…), i ragazzi come intontiti. Arriva l venditore di stoffa inglese, di lino, di percalla, arriva l’incantato venditore di grattate di neve, ma quello che più si corteggia, che più incuriosisce è il venditore ce in un carro a vari ripiani, a cassetti, vende di tutto, le cose più varie, le più belle…
I tao continuano allegramente a saltellare, la mar è con gli occhi alla cima della sua lenta torre, cotto su cotto, formella su formella; il padre porta su, con la solita caparbietà, altre cime, quelle della vita d’orto: ci lavora fin dall’alba, dispone in certo modo le canne, realizza, sempre più assorto, sue geometrie, costruzioni misteriose, oscure. Il cueculo è… ormai sciolto. Ha tenuto tre mesi, però. A squagliarlo non è stato il tepore di uno sbadiglio, né lo scotimento leggero dei seni della madre terra, è stato l’avvolgente e caldo agitatore delle ali dei tao bianchi che prima di tutti avevano captato il magico potere della palla bianca, perfetta, immensa, come una sfida babelica, l’enorme sfida (saldare nel cueculo le spezzature di una lingua, le variegate imperfezioni terrene…) portata da cinque irrisolti mestatori d’incanti che anche stavolta avevano sospettato un cueculo tondo, grosso, immutabile…: la mar – ispiratrice di cotte, di furore – che in inverni come questo aveva tutto previsto, tutto con cenere ideato, aspetta a casa col pan cotto, col boldone!
Girano, vorticano, continuamente i tao in questa cultura, in queste contrade. A mezz’aria. Sono loro i regolatori di questa cultura. Sono loro che, con piroette profumate, sovrintendono agli oggetti, agli attrezzi da lavoro, ai pianti per la figlia che si sposa, alle nenie, alle ballate, alle contra dei trovieri di paese, sono loro che regolano i discorsi, che pizzicano nel sonno, che istigano alle cose insensate, al ridere sfrenato, loro che vivono, si rotolano nella marza preparata per l’innesto, loro che hanno inventato il cane dello Scialla che fece cento chilometri per un bicchiere di vino, la Peppa Landa che compra galline cadenti, il magico lumicino della Lucerna di Iacca, il Morso che ti fa ballare, i giorni della Vecchia, le acchiature in ogni angolo…
Sono i tao regolatori che presiedono agli oggetti, alle situazioni, i momenti di vita che troverete illustrati nel volume. Oggetti, situazioni, momenti che nella loro armonia, nella loro dimensione, nella loro completezza assoluta, vivono anche dell’inaudito che continuamente generano…: e per noi è sempre più chiaro che se le cose hanno tutte un nome, una loro ironia, loro virtù, paradossi, bufferie da tao, è con una lingua che comprenda tutte le lingue che parleremo del sogno, che scriveremo del sogno. Meglio dei sogni, visto che altri balzeranno, altri rotoleranno, piscatori, tra le righe.
(scelta di termini dal) DIZIONARIETTO
dei termini magici, nuovi o non comuni allegato da A. Verri al testo sui Tao
[il] CANE DELLO SCIALLA, LA PEPPA LANDA, LA LUCERNA DI LACCA…: non sono soltanto storie, assolutamente!: sono dimensioni fantastiche, suoni antichi, voci antiche e magiche di un paese e della sua gente.
CONTI: sta per racconti.
CONTRA, [le]: canzoni da contrasto amoroso. Le sentiamo cantare ancora a Borgagne (Le), da due vecchie contadine; il profumo è medievale, di campagna…
COTTA [di pane]: più o meno determinata dalla quantità, di grano o di orzo, impiegata. Una cotta, di solito, è sugli ottanta chili.
CUECULO: per palla, cosa tonda; qui palla magica, bianca…
DECLARO: per dizionario, riandando a fra’ Senisio.
GRATTATE [di neve]: un blocco di ghiaccio in una cassetta piena di paglia, un aggeggio che, grattando leggermente il ghiaccio, si riempie di neve farinosa, un bicchiere pronto a ricevere i cristalli di neve, sono queste le grattate. Ce’ra poi un venditore…
LIBRO VECCHIO [passare al]: espressione popolare [salentina?] per dire che hai concepito e realizzato qualcosa, che da te è nato qualcosa: la nuova nascita, allora, di passare al libro vecchio, l’attenzione, è per euql qualcosa.
LUCCO: anche s eun qualsiasi dizionario vi darà significato diverso, qui è usato, ha significato di cosa magica, lucente, impenetrabile.
MARZA: quello strato umido, sottilissimo, tra la corteccia e il legno. La marza è indispensabile per l’innesto <<a pezza>>.
MATTIRA: grossa madia a forma di barca, nel cui fondo si lavora la farinia.
MERLA, [i tre giorni della]: gli ultimi tre giorni di gennaio, freddissimi, tre giorni che gennaio prese in prestito da febbraio per punire il merlo troppo sicuro di sé.
MULACCHIONA: (non ci stancheremo mai di dire che per noi il plurale è mulacchione), ragazza tonda, passionale, strapiena di carica inesplosa. C’entra la luna…
NATRICI: serpi d’acqua; in questi posti girano, d’estate, intorno a pozzi e cisterne.
NEMBROTICO: d Nembroth, istigatore all’impresa della torre di Babele.
NIBATO: splendido nevoso, da nubo-is o da nix-nivis.
NICARE: nevicare.
NUGOSO: di scherzo, di celia.
PALATA: massa di fichi che si seccherà tra <<pale>>.
PANE COTTO: è pane che si fa bollire insieme a foglie di alloro, prezzemolo e ad un pizzico di peperoncino. Era il piatto rapido saporitissimo, dei contadini. Si mangiava soprattutto d’inverno,a metà mattina, tre, quattro ore prima del pranzo vero e proprio.
PANEGORISARE: sostentare con solo pane.
PESCIOLINI, (liquirizia a): forme dorate di un tempo; non la chiamavano più liquirizia ma pesciolini!
PIRICHILLI – è un termine di un detto, <<pirichilli ca mangia li cardilli>>, ascoltato in Martano (Le), qui usato come folletto di neve.
PREULA: è la vite da orto fatta allungare su delle canne incrociate.
SCISCERI: ventriglio dei polli e degli uccelli.
TANTANTON DE BARBA BIANCA: il proverbio è questo <<Sant’Antonio dalla barba bianca / se non piove la neve norì manca>>; è il cuore dell’inverno, il 17 gennaio.
TAO: folletti dell’aria, della mezz’aria anzi; c’è dentro il salentino mao, il veneto bao, tanto altro…
TRIPIZZO: dolce che si scioglie in bocca rapidamente.
TSIRITRO’: termine dal ritornello di una ballata popolare greca, legatop all’uva, al vino, alla vita allegra.
TUZZUIA: grande cavalletta verde; i danni non si contavano, la gente se la ricorda con terrore.
ZORFO: sta per zolfo, e uncini sta per fiammiferi.
(da “La cultura contadina”, catalogo di una mostra fotografica, Distretto scolastico 42, Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia,maggio 1986, versione pubblicata su Quaderni del Fondo Alberto Moravia, Numero 1, Anno 2002, con scelta dai termini del Dizionarietto)
§
Antonio Verri, “La cultura dei tao”, da Musicaos.it – Anno 2, Numero 18, Giugno 2005
Pagina Facebook di Musicaos.it : http://www.facebook.com/musicaosrivista









 Luciano Pagano
Luciano Pagano
 Elisabetta Liguori
Elisabetta Liguori